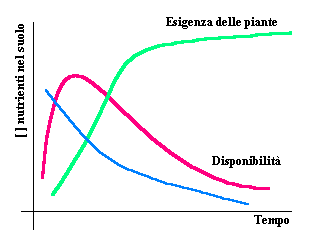
Agricoltura sostenibile: attività che, nel lungo periodo, determina un incremento della qualità dell’ambiente, delle risorse di base ed è economicamente attuabile; essa porta ad un aumento della qualità della vita dei produttori e del tessuto sociale in senso generale (ASA, 1989).
Il rapporto tra florovivaismo e ambiente risenta di alcune grosse contraddizioni interne.
E’ indubbio infatti che questo settore, inteso come produzione di piante ornamentali, esercita un ruolo fondamentale per la salvaguardia dell’ambiente, in termini sia diretti (produzione di materiale vegetale) che indiretti (difesa ambientale, riqualificazione del paesaggio). D’altra parte il florovivaismo rappresenta indubbiamente una forma molto specializzata di agricoltura. L’intensità della coltivazione, spesso elevatissima, richiama una attività di tipo industriale piuttosto che agraria, ed è comunque tale da richiedere dei livelli di input particolarmente elevati, con un consumo, quindi, di risorse consistente, ed un livello residuale spesso preoccupante.
E’ estremamente difficile fornire un quadro aggiornato ed esauriente della problematica legata al controllo dell'inquinamento nel comparto produttivo in esame a causa dell’elevato numero di variabili in gioco. Una prima distinzione dovrebbe essere fatta in relazione al tipo di vivaio in esame:
- vivaio in piena terra
- vivaio in contenitore in piena aria
- vivaio in coltura protetta
Non meno importante è definire ed inquadrare tutte le possibili fonti di inquinamento, o comunque gli interventi determinanti un impatto ambientale di rilievo (es. elevati consumi idrici), legati ad una moderna attività vivaistica. Qui l’elenco potrebbe essere molto lungo, ma uno schema che riassuma i punti critici può essere il seguente:
E’ logico che la scelta di esaminare tutte le variabili sopra citate risulti complicata e poco praticabile, e quindi sembra più opportuno analizzare con attenzione i problemi legati alla gestione, e valutare le soluzioni proposte (o già applicate) facendo di volta in volta riferimenti ai vari tipi di vivaio.
L’argomento, di per sé, riveste una notevole importanza poiché esso rappresenta uno dei pilastri fondamentali per una produzione vivaistica di qualità. In linea generale, il concetto di base che si affronta in questa sede risiede nell’incontro/scontro tra la necessità del produttore di ottenere il massimo risultato dalle proprie colture e l’esigenza di non somministrare dosi tali da non essere completamente impiegate dalle piante e rimanere quindi parzialmente inutilizzate nel terreno per poi confluire nelle falde acquifere sottostanti.
Criteri di uso dei fertilizzanti
E’ necessario in questo contesto operare una distinzione di base tra tecniche di allevamento in terra e tecniche di allevamento fuori suolo: vasetteria, ma anche, ed ancor più, colture orticole in rockwool o NFT. Nel primo caso, la presenza del terreno agrario, con il proprio ampio volume e le caratteristiche fisico-chimiche e microbiologiche, può determinare un forte effetto "volano" sulla coltivazione in vivaio: in pratica anche una gestione non ottimale della coltivazione può essere in qualche modo ammortizzata dal suolo senza che si manifesti una chiara diminuzione della qualità del prodotto. Ciò non significa che l’allevamento in terra sia sotto questo profilo più facile o comunque meno impegnativo delle colture fuori suolo; è vero semmai l’opposto, nel senso che l’azione cuscinetto del terreno agrario rende più difficile un monitoraggio corretto della fertilizzazione e quindi anche una valutazione dei possibili interventi sulle colture in atto. E’ comunque possibile fornire alcune indicazioni, ancorché generali, di comportamento per minimizzare i rischi di un sovradosaggio nella fertilizzazione:
Diverso è il caso della coltivazione in contenitore, così come viene intesa attualmente. In realtà, nelle sue espressioni iniziali, l'allevamento in contenitore prevedeva l'uso di terreno agricolo come mezzo di coltura, di conseguenza, le pratiche di fertilizzazione erano molto simili a quelle di campo, avendo il terreno agricolo una buona disponibilità organica ed inorganica, e pertanto di norma la fertilizzazione non rappresentava un fattore limitante la crescita. Negli ultimi 20 anni, invece, si è progressivamente passati a substrati colturali "artificiali", costituiti in larga parte da materiali inerti (perlite, pomice, vermiculite, sabbia) e la rimanente parte da materiali organici (in Italia in genere torba). L'uso di questi nuovi materiali, di norma aventi un ridottissimo peso specifico (che li rende vantaggiosi per tutte le operazioni di spostamento e trasporto), ha determinato una trasformazione profonda delle caratteristiche fisico-chimiche del substrato, ormai ridotto a solo supporto fisico per la pianta, essendo dotato di una ridottissima disponibilità di nutrienti inorganici. La prima conseguenza di questo fatto è rappresentata dall’importanza che la nutrizione ha assunto con questo tipo di tecnica (Tattini, 1990), diventando condizione irrinunciabile per la coltura, al pari della stessa acqua.
Purtroppo, però, i problemi già accennati nel caso della coltivazione in pieno campo diventano qui ancora maggiori, in quanto:
1 – il limitato volume del contenitore, unito alle caratteristiche chimico-fisiche dei substrati non consente alcun accumulo di elementi nutritivi, che devono quindi essere somministrati con continuità.
2 – le piante, peraltro, sono in grado di assumere concentrazioni crescenti di un elemento nutritivo solo fino ad una certa soglia, oltre la quale l’assorbimento dell’elemento stesso è indipendente dalla sua concentrazione (Nissen, 1986); ciò significa che, passata tale soglia, tutto quello che viene somministrato in più non viene utilizzato dalla pianta, e, mancando di fatto una capacità di adsorbimento del substrato, viene ad essere perso nelle acque di percolazione.
Dopo queste brevi considerazioni, possiamo tentare di dare qualche indicazione per limitare l’impatto ambientale derivante dall’uso dei fertilizzanti nell’allevamento in contenitore:
Tipo di fertilizzanti utilizzati
Come è noto esiste una grande varietà di prodotti e tipi di somministrazione per la fertilizzazione delle colture. Vediamo di fare una breve disamina delle principali categorie nei riguardi del loro effetto sull’ambiente.
Fertilizzanti minerali: sono i classici prodotti utilizzati in agricoltura (urea, NH4NO3, K2SO4, ecc.). Il loro utilizzo è alquanto in calo dopo l’avvento dei nuovi prodotti a lenta cessione; in ogni caso soprattutto gli azotati sono talvolta distribuiti al suolo o aggiunti nei substrati, ed allora è bene sapere che la loro permanenza è molto modesta. E’ stato visto che il dilavamento dell’N in colture in contenitore presenta un picco dopo solo 9-10 giorni dall’applicazione, e addirittura 5 giorni se c’è stato un violento acquazzone (Mac Carthaig, 1994); le stesse ricerche hanno evidenziato che la quasi totalità di N viene dilavata in 15 gg in periodi di piovosità media giornaliera di 18 mm.
Fertilizzanti a lento effetto non confettati: è questo un gruppo di prodotti che sta avendo una recente, notevole diffusione (es. Nitrophoska). Sono prodotti aggregati nei quali una parte è rappresentata da fertilizzanti minerali a rapida azione, mentre una parte (in genere il 30% circa) è legata in complessi che vengono lentamente liberati per via microbiologica (2-3 mesi circa). Il migliore uso che si può fare di questi prodotti è in copertura, in sostituzione dei fertilizzanti minerali, nei confronti dei quali, avendo una solubilizzazione più progressiva, risultano essere preferibili oltre che per una migliore azione nutritiva, per un minore dilavamento. Ricerche svolte sulla concentrazione dei nitrati in acqua di scolo in un vivaio in contenitore hanno evidenziato che la fertilizzazione con solo prodotti a lento effetto determina concentrazioni di 0,5-33 ppm contro concentrazioni di 0,1-133 ppm per fertilizzazioni miste [10 ppm per acqua potabile] (Latimer et al., 1996).
Fertilizzanti a lento effetto confettati: anche questo gruppo di prodotti ha trovato una sua ampia diffusione nel settore vivaistico (es. Osmocote, Nutricote, Multicote). Sono costituiti da granuli di concime rivestiti da resine, che possono essere organiche naturali, acriliche, cere o lattici. Lo spessore e la composizione di queste resine determinano la durata del prodotto; esse non impediscono all'acqua di entrare, cosa che provoca una solubilizzazione dei prodotti all'interno dei granuli. Il fertilizzante solubilizzato inizia a fuoriuscire gradualmente dal rivestimento di resina, e la velocità di fuoriuscita è, tra i parametri fisico-chimici, unicamente funzione della temperatura. Generalmente i prodotti commerciali riportano una durata media riferita a 21°C nel terreno. In linea generale questi prodotti sono utilizzati nella preparazione dei substrati per vasetteria, e quindi hanno una utilizzazione diversa rispetto al gruppo precedente. Essi vanno, di fatto, a costituire nel contenitore quella che nell’impianto di un arboreto (frutteto) è definita come concimazione di fondo. In letteratura non si trovano molti riferimenti sulla dilavabilità, e quindi sull’impatto ambientale di questi prodotti. E’ stato comunque visto che la maggior parte della perdita di nutrienti dai contenitori avviene nelle prime due settimane e questo per perdite della frazione organica e per dilavamento di granuli mal confettati (Creswell, 1995). Ciò che viene sottolineato è che questi fertilizzanti rispettano i tempi dichiarati di persistenza (6-9-12 mesi) se vengono impiegati alle temperature indicate; la degradazione della confettatura è molto più influenzata dalla temperatura che dai regimi idrici e quindi un loro impiego "ecologicamente" corretto implica di evitare per quanto possibile di usarli ad alte temperature ambientali (stagione calda o ambienti protetti).
Fertilizzanti liquidi: vengono distribuiti con l’impianto di irrigazione e la pratica viene definita fertirrigazione. Se da un punto di vista tecnico la fertirrigazione può presentare alcune difficoltà, va però detto che essa consente di fertilizzare in accordo con lo sviluppo della pianta. E' infatti ovvio che le dimensioni e quindi l'assorbimento di nutrienti aumentano nel tempo, e la cosiddetta "nutrizione in stato stazionario" (Ingestad, 1982) è così facilmente realizzabile al contrario di quanto si possa realizzare con fertilizzanti a lenta cessione. Per di più con la fertirrigazione non si pongono i problemi che possiamo avere con i prodotti a lento effetto che, per quanto perfezionati, tendono comunque a rilasciare la maggior parte dei nutrienti nel primo periodo, quando la pianta non ha ancora un efficiente apparato radicale e non è quindi in grado di utilizzarlo, per poi entrare in crisi con l'azoto dopo 4-5 mesi (vedi figura sotto). La perdita di fertilizzante, già solubilizzato nell’acqua, è qui strettamente legata alla gestione dell’irrigazione: ogni ml di acqua che percola da un vaso o si perde nel terreno (nella piena terra) è di fatto una contaminazione dell’ambiente.
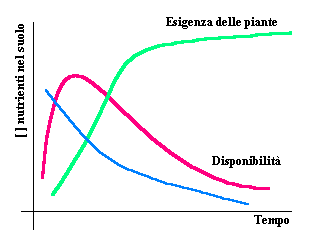
Questo capitolo è particolarmente delicato poiché chiama in causa quel tipo di prodotti che più di ogni altro contribuisce a gettare ombre sulla possibilità di un efficace controllo dell’inquinamento in vivaio. In realtà, da un punto di vista strettamente tecnico, gli aspetti relativi alla difesa delle colture ed alle loro implicazioni in chiave ambientale risultano essere alquanto lineari. Per prima cosa dobbiamo fare una distinzione sia tra tipi di prodotti impiegati, sia in relazione alla loro modalità di somministrazione.
La difesa delle colture in vivaio si combatte essenzialmente su due fronti:
Relativamente alle modalità di somministrazione dei suddetti prodotti, possiamo avere i seguenti casi:
L’impatto ambientale derivato dall’uso di questi prodotti è un fatto ormai accertato, almeno nelle zone caratterizzate da elevata vocazione vivaistica. Un recente studio dell’ARPAT (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana) svolto nel comprensorio pistoiese a carico delle acque superficiali (Ombrone, Brana, Bure, Stella, Dogaia, ecc.) ha rilevato come per la maggior parte dei principi attivi ricercati siano stati rilevati in più punti livelli di picco e trend positivi per oxadiazon e pendimethalin, mentre una situazione migliore è stata rilevata per simazina, propyzamide, metalaxyl, propoxur, sebbene anche per questi prodotti siano stati registrati isolati casi di alta concentrazione nei campioni di acqua (ARPAT, 1997).
Dalla ampia letteratura esistente sull’uso (ed abuso) di questi prodotti e sul loro impatto ambientale, è probabilmente possibile trarre alcune utili indicazioni:
dichlobenil > simazina > trifluralin ~ nitralin ~ DCPA (Elmore et al., 1976).
Aggregando tutti i dati di questo genere disponibili in bibliografia, unendoli alle caratteristiche del prodotto è probabilmente possibile fare un elenco dei prodotti in base alla loro crescente mobilità nel suolo o nei substrati.
Questo significa, in sostanza, che i substrati dotati di una frazione organica ridotta o comunque con ridotta capacità di adsorbimento avranno alla lunga un "costo ambientale" rilevante in quanto lasceranno percolare il prodotto rapidamente e obbligheranno il produttore ad interventi più ravvicinati.
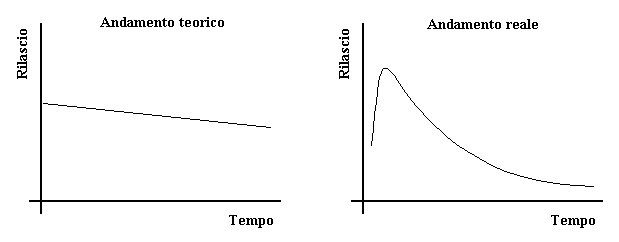
E’ particolarmente scioccante un dato: da ricerche svolte è emerso che dal 5% all’8% circa di prodotti granulari (oryzalin, oxyfluorfen, isoxaben) dati in copertura sono stati asportati con la prima irrigazione (Whitwell et al., 1995, Wilson et al., 1993). Questo aspetto induce a sottolineare l’importanza del regime irriguo, che, dopo la distribuzione del trattamento, dovrebbe essere particolarmente misurato.
Anche i diserbanti sono stati perfezionati e le loro dosi di uso sono in costante diminuzione: prodotti a base di sulfonilurea, che sostituiscono la triazina, agiscono a dosi 20-300 volte inferiori rispetto a quest’ultima.
E’ chiaro che uno schema come quello appena riportato può rappresentare una semplificazione eccessiva anche perché, rimanendo nell’ambito dei funghi responsabili dei marciumi radicali, non dobbiamo scordarci che ne esistono di molti specie (Fusarium, Pythium, Cylindrocarpon, Cylindrocladium, Phytophthora, ecc.). Lo sforzo è quindi quello di ampliare il quadro della difesa integrata, aumentando se necessario il numero di fungicidi usati, mantenendo quelle indicazioni che possono andare bene per tutti questi patogeni e eliminando quelle che potrebbero bloccare un patogeno ma stimolarne un altro: ad es. il pH molto basso contrasta efficacemente la Rhizoctonia ma può favorire lo sviluppo di Fusarium e di Cylindrocarpon..
Esistono inoltre altre vie percorribili nell’ambito delle nuove strategie di difesa: ricordiamo il controllo biologico degli agenti patogeni, intorno al quale c’è molto interesse anche se molto lavoro resta da fare.
Caratteristiche chiave per un organismo biologicamente attivo contro patogeni sono:
1) – elevata capacità di crescita;
2) – sopravvivenza ed elevata attività biologica per lunghi periodi in condizioni ambientali anche molto differenziate;
3) – stabilità genetica e assenza di pericolosità per animali, piante e ambiente in senso lato;
4) – fornire un buon controllo del patogeno-bersaglio.
Si deve rilevare che la ricerca ha maggiori difficoltà ad identificare agenti di controllo biologico per patogeni sovra-suolo rispetto a patogeni del suolo, e questo principalmente perché l’ambiente suolo presenta condizioni di umidità molto più costanti e ciò è favorevole agli agenti del biocontrollo. Questi ultimi sono naturalmente presenti nel suolo e possono essere funghi, batteri ed actinomiceti; il loro meccanismo di azione può essere di varia natura: possono produrre antibiotici specifici per il patogeno, possono parassitizzare il patogeno da cui ottengono nutrienti o fattori di crescita oppure, infine, possono competere con loro per fattori di crescita quali la luce, il cibo, ecc..
Uno degli agenti più noti è il Trichoderma viride attivo contro Botrytis, ma anche contro vari patogeni del marciume radicale in vivaio. Un altro agente interessante è il Mycostop, un actinomicete molto valido, sembra, nel bloccare agenti del marciume quali Alternaria e Fusarium nella floricoltura e nella orticoltura sotto serra. Un ultimo esempio può essere il Blue Circle ® un agente batterico (Pseudomonas cepacia) molto interessante per i marciumi radicali nelle orticole di pieno campo e di serra (Holmes e Litterick, l.c.).
Un particolare filone di ricerca da seguire con interesse è quello dei micoerbicidi ; in sostanza questi prodotti contengono grandi quantità di spore di un fungo che è specifico per una certa erba infestante, e che può risultare fatale a quest’ultima se applicato in specifiche fasi del ciclo dell’erba. Ovviamente l’applicazione in vivaio non presenta rischi per l’ambiente anche perché questi funghi non sono in grado di svernare; nel breve o medio termine non sembra comunque che si possa passare alla fase applicativa di questa categoria di prodotti.
Un ultimo tipo di approccio alternativo alla difesa delle colture può essere rappresentato da una prevenzione biologica contro attacchi parassitari; l’esempio migliore è rappresentato dagli inoculi micorrizici che svolgono la loro azione benefica ampliando i sistemi radicali, aumentando la disponibilità di risorse (acqua, elementi minerali), ed operando una protezione diretta delle radici dell’ospite. Una certa azione in questo senso è anche svolta, molto più semplicemente, da certi "ingredienti" per i substrati quali torbe poco decomposte, ricche di materiale vegetale, o scorza d’albero (pino, in genere) compostata.
Per concludere l’esame sull’impatto ambientale della difesa delle colture, è opportuno fare alcune considerazioni su un argomento particolare, e cioè l’uso di prodotti fumiganti nel suolo, in coltura coperta o in piena aria, allo scopo di azzerare i rischi di contaminazioni (funghi, insetti, nematodi, infestanti) fra un ciclo colturale e l’altro. Il prodotto più usato per questa operazione è stato sinora il bromuro di metile, ed il settore vivaistico ne ha assorbito circa il 20-25% di tutto il bromuro usato in agricoltura. Questo prodotto, peraltro, dovrà in un prossimo futuro essere sostituito in quanto è risultato essere molto aggressivo nei confronti della fascia di ozono (già molto provata da altri agenti – es. CFC), e già paesi come gli USA hanno fornito una data (2001) per un divieto totale di produzione, importazione e uso del bromuro di metile. Appare quindi urgente trovare delle alternative "sostenibili".
Alla luce delle ricerche attuali sembra che una via possa essere l’uso del vapore di acqua; sono già stati sperimentati alcuni prototipi per vivaio piuttosto interessanti. Il vapore colpisce gli stessi "targets" del bromuro, non è fitotossico e ha un costo di solo uso, sembra, inferiore al bromuro consentendo quindi di ammortizzare un eventuale acquisto in pochi anni. La tecnologia attuale permette di assemblare macchine simili a seminatrici con tubi che sparano vapore a seguito di aratrini a circa 6-8 cm di profondità; queste macchine sono però un po’ lente e la distribuzione del vapore non sembra omogenea; in futuro si pensa di tentare con macchine che "mangino" i primi 10-12 cm di suolo, lo trattino in camere a vapore per poi rilasciarlo dietro (Quarles, 1997).
Il problema della gestione dell’acqua in vivaio è, almeno nelle sue linee essenziali, piuttosto lineare. L’acqua è senza dubbio il primo fattore, l’elemento più importante della produzione di piante, ma è anche certamente il fattore peggio utilizzate nel processo produttivo. In realtà, sia affrontando il tema della gestione nutritiva che della difesa delle coltivazioni si è già accennato a quello che è il punto cruciale della questione: l’assoluta necessità di diminuire il consumo di acqua cercando al tempo stesso una sua migliore distribuzione. Vediamo adesso i punti salienti di questa problematica:
Prima di concludere è giusto accennare, nell’ambito della problematica della salvaguardia dell’ambiente, a due aspetti ben distinti che riguardano il vivaio in contenitore. Un primo aspetto, negativo, è relativo all’uso dei teli impermeabilizzanti per le superfici di coltura dei vasi: è da tempo in atto una forte polemica sul possibile disturbo che l’uso di tali teli possa rappresentare nei rapporti tra acque superficiali e acque sotterranee, determinando un rischio di inquinamento della falda. In realtà il danno che questi materiali possono causare all’ambiente va oltre i semplici rapporti idrici tra superficie e sottosuolo, ma investono anche altre componenti. In particolare ci sono rischi a carico della microflora e microfauna per i ridotti scambi con l’atmosfera, alterazioni sono inoltre probabili alle dinamiche di infiltrazione delle acque aumentando il coefficiente di deflusso ed è possibile che ci siano anche aumenti localizzati, ma molto intensi, della vulnerabilità delle acque sotterranee (Pranzini, 1996). D’altra parte una quantificazione dei problemi sopra citati è difficoltosa a causa soprattutto delle diverse tipologie di teli utilizzati: il polietilene classico impermeabilizza totalmente la superficie dove viene applicato, mentre il geotessile, oggi in forte espansione, è caratterizzato da una semipermeabilità che consente almeno l’infiltrazione idrica. Anche le diverse modalità di messa in opera di questi materiali ha la sua importanza: se i teli sono semplicemente appoggiati sul terreno, vanno incontro in tempi brevi a lacerazioni, aperture dovute all’uso, deterioramento per la radiazione solare, mentre se sono coperti con uno strato di ghiaia, la loro persistenza, e la loro impermeabilità, aumentano sensibilmente.
Un secondo aspetto, questo positivo, è relativo ad una opportunità che in futuro si aprirà per il comparto vivaistico. Già da tempo si fa un gran parlare, e tentativi sono già stati effettuati, della possibilità di sostituire, nella coltura in contenitore, la torba con una frazione organica di diversa matrice, e cioè il compost.
Agricoltura, industrie ed agglomerati urbani forniscono annualmente tonnellate di sottoprodotti il cui recupero ed impiego, nell’ambito di una politica di contenimento dell’inquinamento ambientale è argomento di scottante attualità. Uno dei possibili e più opportuni usi di questi materiali è rappresentato dalla trasformazione di questi in compost da essere utilizzati in agricoltura, non già come mero collocamento del rifiuto, bensì come risorsa di crescente importanza (Zucconi e de Bertoldi, 1982). D’altra parte la torba, base della frazione organica nei substrati di oggi non è una risorsa illimitata, il suo prezzo è in costante ascesa negli ultimi anni e già in alcuni paesi produttori, come la Germania, sono state emanate leggi restrittive sulla estrazione di questo materiale (Bruns, 1994). E’ ipotizzabile che entro 10 anni i produttori italiani di piante in contenitore si trovino a operare scelte radicali in questo senso, e comunque va ricordato che taluni paesi, come la Nuova Zelanda, ritengono di avere un bagaglio scientifico e sperimentale sull’uso di prodotti alternativi tale da dichiararsi già da tempo pronti a fare a meno della torba nella produzione vivaistica (McPherson, 1992).
In conclusione il settore vivaistico è chiamato ad un passaggio difficile ed importante. La società ormai chiede che le responsabilità per chi svolge una attività ad elevato impatto ambientale ricadano sul produttore stesso, e quindi la strada della sostenibilità in vivaio non sarà alla fine una scelta lasciata al produttore, ma una via obbligata da percorrere. Il pericolo maggiore, a medio-lungo termine, risiede nella possibilità che il nostro paese, ormai integrato in una comunità europea a sua volta soggetto politico protagonista in uno scenario mondiale, si trovi di fronte ad una serie di rigide scadenze imposte, di fronte alle quali ci troveremmo, c’è da crederci, in uno stato di totale emergenza. A titolo di esempio citiamo il caso del governo olandese che, nella necessità di ridurre l’inquinamento nella sua produzione florovivaistica sotto serra ha chiesto ai produttori di orientarsi verso sistemi produttivi chiusi (closed systems) con totale ricircolo delle risorse (acqua, fertilizzanti); gli obiettivi per l’anno 2000 sono stati così individuati (Biggs, 1994):
E’ evidente che, sebbene alcuni degli obiettivi sopra indicati sembrino di difficile conseguimento nei tempi indicati, rimane il significato politico della direttiva, che assume il valore di una spinta verso una autentica sostenibilità dell’intero comparto produttivo.
Amos R.R., 1993 – Reduction of nitrates in nursery surface and ground water. Comb. Proc. International Plant Propagator Society, 43: 244-248.
Andrews M.W., 1995 – Irrigation tailwater regulations in 1990’s. Comb. Proc. International Plant Propagator Society, 45: 574-576.
ARPAT, 1997 – Impatto ambientale delle pratiche vivaistiche. Dipartimento provinciale di Pistoia.
Biggs A.G., 1994 – Waste management in horticulture – The global perspective. Comb. Proc. International Plant Propagator Society, 44: 41-44.
Briggs J., Whitwell T., 1997 – Minimize the pesticide exodus. American Nurseryman, June: 58-67.
Bruns J.D., 1994 – The latest environmental restrictions on nursery production in Germany: is nursery production still possible? Comb. Proc. International Plant Propagator Society, 44: 138-141.
Cresswell G.C., 1995 – Improving nutrient and water management in nurseries. Comb. Proc. International Plant Propagator Society, 45: 112-116.
Elmore C.L., Ahrens J.F., Humphrey W.A., 1976 – Leaching of herbicides in container mixes. Plant Propagator, 22: 7-10.
Enoch H.Z., Olesen J.M., 1993 – Plant response to irrigation with water enriched with carbon dioxide. New Phytologist, 125: 249-258.
Holmes S., Litterick A., 1994 – Can disease ever be environment friendly? Comb. Proc. International Plant Propagator Society, 44: 156-160.
Iyer J.G., Steele S., Camp R.F., 1989 – Plant nutrients removed by nursery stock. Tree Planter’s Notes, 40 (1): 8-11.
Latimer J.G., Oetting R.D., Thomas P.A., Olson D.L., Allison J.R., Braman S.K., Ruter J.M., Beverly R.B., Florkowski W., Robacker C.D., Walker J.T., Garber M.P., Lindstrom O.M., Hudson W.G., 1996 – Reducing the pollution potential of pesticides and fertilizers in the environmental horticultural industry: I. Greenhouse, Nursery and Sod production. Hortechnology, 6(2): 115-124.
Mac Carthaig D., 1994 – Environmental aspects of fertilizing container plants. Comb. Proc. International Plant Propagator Society, 44: 182-186.
McPherson D., 1992 – Is horticulture industry in New Zealand environmentally friendly? Comb. Proc. International Plant Propagator Society, 42: 318-320.
Nelson P.V., 1990 – Developing root zone management strategies to minimise water and fertiliser waste: the United States perspective with emphasis on surface applied non-recirculated systems. Acta Horticulturae, 272: 185-190.
Parris J.K., 1995 – Application of Israeli low-volume irrigation technology. Comb. Proc. International Plant Propagator Society, 45: 582-584.
Pranzini G., 1996 – Carta della vulnerabilità all’inquinamento delle acque sotterranee di pianura. Comune di Pistoia (Relazione tecnica preliminare).
Quarles, W., 1997 – Steam, the hottest alternative to methyl bromide. American Nurseryman, 37-43.
Shiflett M.C., Niemiera A.X., Leda C.E., 1994 – Mid-season reapplication of controlled release fertilizers affect "Helleri" holly growth and N content of substrate solution and effluent. Journal of Environmental Horticulture 12(4): 181-186.
Tattini M., 1990 - Aspetti teorici e pratici di nutrizione minerale per specie allevate in contenitore. Lineaverde, n°1, pag.67-72.
Whitwell T., Briggs J.A., Riley M.B., Camper N.D., 1995 – Fate of herbicides in container nursery runoff. Comb. Proc. International Plant Propagator Society, 45: 570-573.
Wilson C., Bandary R., Whitwell T., Riley M., 1993 – Movement, dissipation and impacts of Isoxaben (Snapshot TG) in nursery runoff water. Comb. Proc. International Plant Propagator Society, 43: 408-412.
Yelanich M.V., Biernbaum J.A., 1990 – Effect of fertiliser concentration and method of application on media nutrient content, nitrogen run-off and growth of Euphorbia pulcherrima. Acta Horticulturae, 272: 185-190.
Zucconi F., de Bertoldi M., 1982 – Utilizzazione in agricoltura dei prodotti di trasformazione dei composti solidi urbani. Ingegneria Ambientale, 11(2): 110-117.

